Comunicazione è una delle tante parole abusate e svuotate: nella ‘società della comunicazione’, essa è ovunque e alla fine da nessuna parte, e ormai copre forme che ben poco hanno a che vedere con il significato più profondo di questa parola. Un significato coestensivo all’umano: in quanto esseri relazionali siamo esseri comunicanti. La relazione precede il nostro essere individui e lo fonda, perché diventiamo chi siamo sempre in relazione ad altro e ad altri. La comunicazione non è quindi una funzione, un’azione, ma l’espressione della relazionalità che ci costituisce, la manifestazione della nostra essenza più profonda, del nostro essere-con. Anche per questo, come sosteneva Watzlavick, ‘Non si può non comunicare’.
Per liberare questa parola dai suoi usi distorti e fuorvianti si può partire dall’etimologia, che è sempre un modo fecondo di prendersi cura delle parole perché le ripulisce da tutte le incrostazioni di banalità e luoghi comuni che le hanno impoverite e rese, alla fine, incapaci di significare.
L’origine è communis, da cum-munus, dove munus è il dono dovuto alla comunità e da essa riconosciuto. Ed è il contrario di immunis, che vuol dire ‘sciolto da ogni obbligo’.
Questa radice aiuta a decostruire molte cattive definizioni di comunicazione: una critica necessaria per restituire pienezza a questa parola.
Siamo abituati a pensare la comunicazione come ‘trasmissione’, come ‘dire qualcosa a qualcuno’, facendo transitare un contenuto (già definito) da un emittente a un ricevente.
Questa è un’accezione riduttiva sotto molteplici punti di vista.
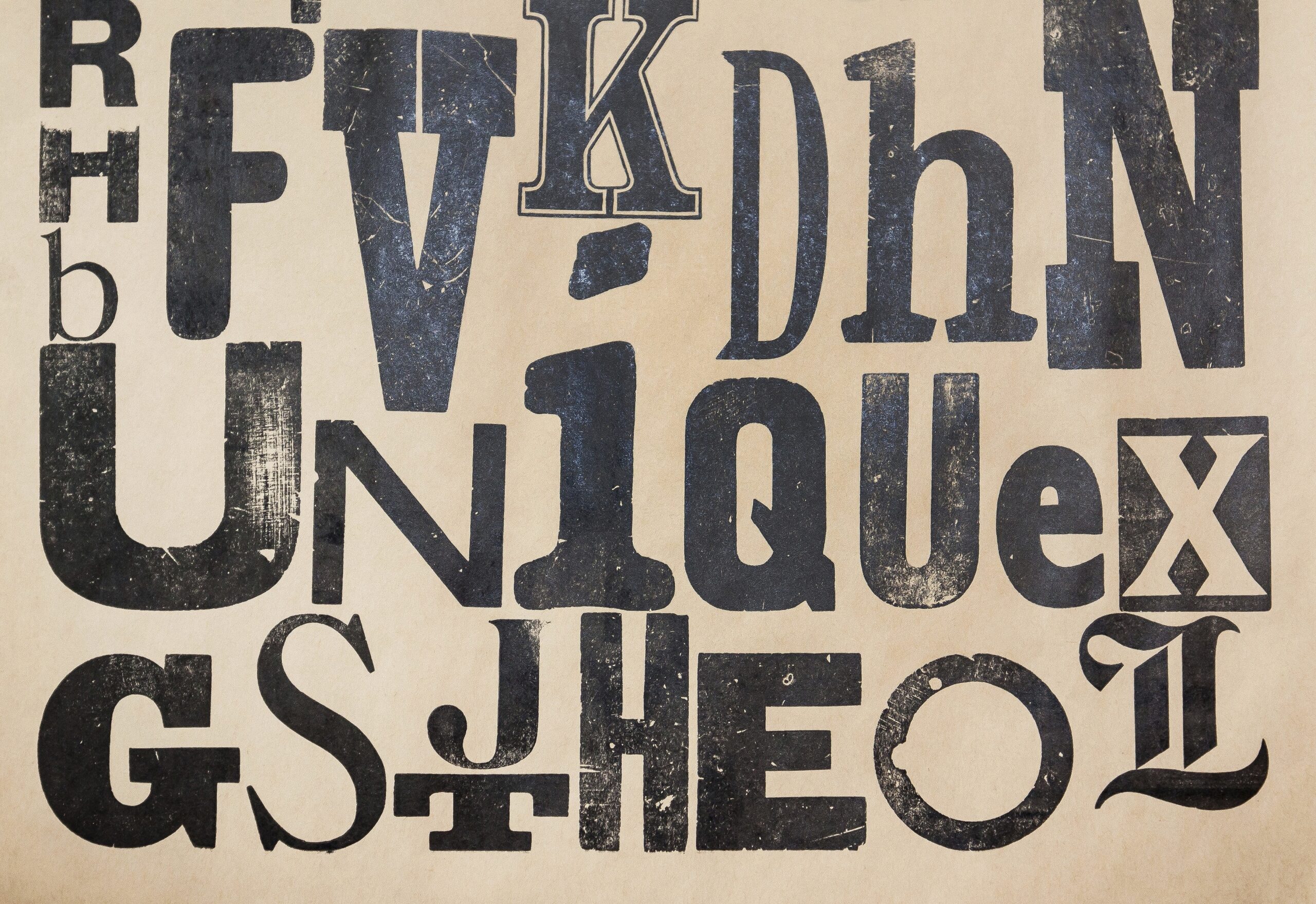
Intanto la comunicazione non è solo ‘dire cose’, non è fatta solo di linguaggio verbale, ma è un fenomeno integrale e complesso, che coinvolge tutta la persona, il modo in cui dispone il suo corpo nello spazio, la distanza alla quale tiene l’interlocutore e molti altri aspetti, non riducibili a un messaggio codificato nel linguaggio verbale.
In secondo luogo, se ci atteniamo alla radice etimologica del mettere in comune, in una prospettiva relazionale, possiamo dire che il primo passo della comunicazione non è l’enunciazione bensì il silenzio, che è condizione dell’ascolto. Senza ascolto non c’è incontro reale, e non può esserci una reale condivisione. Il silenzio, suggeriva la filosofa Luce Irygaray, allestisce lo spazio propizio in cui l’altro si sente accolto e valorizzato, perché il dialogo possa essere realmente fecondo.
In terzo luogo, il modello della comunicazione come trasmissione, non a caso formulato da due ingegneri (Shannon e Weaver, negli anni ‘50) è plasmato sulla comunicazione tra macchine che emettono e ricevono segnali. Il messaggio, opportunamente codificato, transita in un canale senza alcun tipo di modifica, a meno che non intervengano fattori perturbanti (il ‘rumore’) a rendere più difficoltosa la ricezione (decodifica). Si tratta a tutti gli effetti di una ‘cattiva sineddoche’, che estende un caso particolare (e nemmeno il più significativo) all’intera comunicazione umana, che è molto più ricca e complessa. Il modello della trasmissione vale tuttalpiù per il passaggio di informazioni, ma non è questa la forma più emblematica della comunicazione. Il rischio – evidente nelle società avanzate – é che riusciamo a far funzionare perfettamente tutto, ma non siamo più capaci di intenderci su niente.
Un’altra fonte di distorsione molto evidente oggi è l’estensione del linguaggio tecnoscientifico, composto di termini perfettamente aderenti ai loro referenti, univoci e orientati alla classificazione e al controllo, a tutti gli ambiti della comunicazione umana, che invece si serve di parole, sempre dense, polisemiche, aperte, e, soprattutto, rivolte ad altri. La parola chiama in causa un altro da cui ci aspettiamo che la nostra fiducia venga accolta e ricambiata. Come ha scritto recentemente Giorgio Agamben, “vi è un ‘dire’ (lègein) che non dice semplicemente, ma apostrofa e chiama, e ‘chiamare’, ‘dar nome’ e ‘rivolgere la parola’ sono strettamente intrecciati”.
Possiamo usare un linguaggio che ci permette di designare, possedere, controllare, manipolare la realtà ma anche un linguaggio che ci lega al mondo, agli altri, che instaura e riconosce un legame che è inesauribile: è la dimensione simbolica della comunicazione.

Con le parole si può dialogare, con i termini no. Ramon Panikkar distingueva tra dialogo dialogico e dialogo dialettico. Il primo è un logos che lega, che avvicina; è un processo di progressiva riduzione della distanza che si svolge nel tempo, facendo crescere ciò che accomuna. Il dialogo dialettico, quello cui siamo più abituati soprattutto nella comunicazione televisiva e sulle piattaforme social, parte invece da una spazializzazione delle posizioni: è la logica dello schieramento, dove non conta tanto quello che si dice, ma da che parte si sta. È una guerra, dove il fine è radicalizzare le differenze e cercare di neutralizzare, annientare, distruggere l’avversario. In un certo senso questo è il contrario della comunicazione, almeno nel senso etimologico. Ma è purtroppo la forma dominante che pervade sfera pubblica, e quella a cui tutti si stanno alla fine assuefacendo.
Comunicare è, piuttosto, ingaggiarsi in un processo i cui esiti non sono predefiniti. E non è far transitare un contenuto già dato da un punto a un altro, bensì far esistere qualcosa che non c’era ancora, dato che l’esito del processo non è scontato, né deducibile dalle posizioni di partenza. Per questo la comunicazione è ‘generativa’, non solo trasmissiva, né solo espressiva di sé; è capace di dare forma nuova all’esperienza e alle relazioni, accorciando le distanze e facendo crescere ciò che unisce – il communis appunto.
La comunicazione generativa è anche trasduttiva, poiché mette al mondo ciò che non c’era, trasformando le incompatibilità in forme di ricomposizione inedita che diventano il punto di partenza, anch’esso dinamico, di nuove forme di individuazione collettiva.
Come scriveva in un importante saggio James Carey alla fine degli anni ‘80. “Se il caso archetipico di comunicazione intesa come trasmissione è la diffusione dei messaggi nello spazio a fini di controllo, il caso archetipico di comunicazione intesa come rituale è la cerimonia sacra che avvicina le persone in amicizia e comunanza”.
Questo riavvicinamento, questa costruzione dialogica del ‘comune’ parte dal riconoscimento di essere una ‘comunità di destino’ in quel villaggio globale, benché fratturato al proprio interno, che è il mondo di oggi. E riconoscere ciò che è comune non solo non è un ostacolo, ma anzi è la condizione perché ciascuno possa diventare se stesso, esprimere la propria unicità: “La ricchezza di ogni gruppo umano risiede nella comunicazione, nell’aiuto reciproco e nella solidarietà che mirano a un obiettivo comune: la realizzazione di ogni individuo nel rispetto delle differenze”, scriveva la psicanalista Françoise Dolto.
La comunicazione è perciò la via della crescita personale e sociale. “La comunicazione è condizione di reinvenzione permanente della cultura” (Gilbert Simondon).
È possibile una comunicazione generativa nell’ambiente digitalizzato in cui ci troviamo a vivere oggi, e che diventa sempre più pervasivo?
I media, anche quelli che non vengono comunemente tacciati di produrre fake news, si sono persi in un gioco di specchi fra entropia, caos, disordine, dedifferenziazione e omologazione. Questo gioco di specchi rende i soggetti incapaci di trovare quei significati comuni attorno ai quali fare comunità, raccogliendosi e decidendo come agire, e agire altrimenti da quanto sembra inevitabile (secondo l’acronimo fatalista TINA, there is no alternative), in una maniera che non sia solo reattiva, ma creativa e libera.
Poiché le questioni della società del controllo, del capitalismo della sorveglianza, della governamentalità algoritmica si fanno sempre più concrete e preoccupanti, e dato che la digitalizzazione è oggi uno dei principali vettori del cambiamento, è fondamentale creare le condizioni per rigenerare una modalità di comunicazione che non ci consegni alla distopia Foucaultiana individualizzazione / totalizzazione. Una comunicazione dove ciascuno, come persona e come gruppo, possa portare il contributo della propria unicità a un orizzonte di senso comune, che così diventa plurale, variegato e ‘transindividuale’: una dimensione fondamentale, simbolica, fatta di significati collettivi condivisi e trasmissibili tra le generazioni, in cui potersi riconoscere per vivere insieme. Che si fonda sull’investimento educativo, presupposto di ogni società che vuole sperare di realizzare forme di convivenza pacifiche ed evolute.
E ciò è particolarmente importante in un mondo sempre più entropico, dove cresce la misura del disordine, che esplode in frammenti che non si parlano, dove la pluralità e la varietà si riducono.
Prendersi cura della comunicazione significa impegnarsi perché il linguaggio sia un ponte e non un muro, un abbraccio e non un’arma, valorizzando la sua capacità di legame (legein come appunto ‘parlare’ e ‘unire’).
La comunicazione dialogica è generativa perché non si limita a trasmettere un contenuto che già esiste; è molto più della lotta o della somma di posizioni, ma genera qualcosa che non c’era, una comunanza nuova, una reciprocità che cresce, una disponibilità a lasciarsi convocare dall’ascolto della realtà e dell’altro.
E il dialogo dialogico è possibile anche in rete. È vero che sono sempre più virali i messaggi polarizzati, non di rado alimentati ad arte. Però è pure vero che la rete consente anche di mobilitarsi insieme, di condividere saperi, di ridurre le distanze.
Sta a noi cogliere l’ambivalenza tra dimensione tossica e curativa del digitale e valorizzare la seconda.
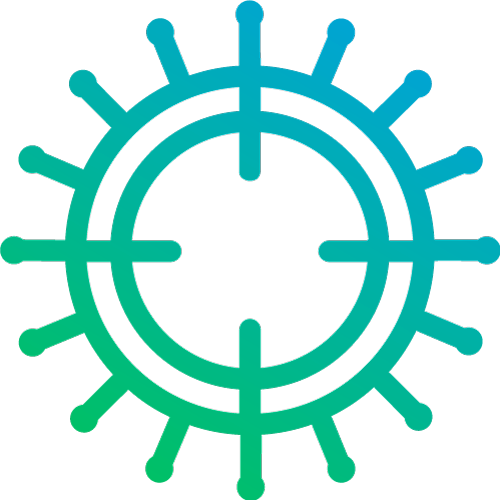
Allestire spazi, anche digitali, dove superare la frammentazione che rende faticose e inefficaci le azioni di singoli e gruppi; valorizzare le iniziative, le proposte, le azioni di enti, istituzioni, associazioni e imprese, facendone emergere l’unicità e il grande potenziale contributivo; rigenerare un lessico che consenta di intendersi, di superare le distanze, di ricostituire un tessuto propositivo, di progredire in un ‘dialogo dialogico’ che rivitalizzi il Paese e sia in grado di fare massa critica, di diventare un interlocutore delle politiche e delle istituzioni.
Piano B non è un ulteriore soggetto enunciatore che entra sulla scena pubblica, bensì uno spazio di incontro, di dialogo, di sintonizzazione di intenti e progettualità che si pone a servizio dei tanti soggetti che già operano, cercando di superare la frammentazione e di valorizzare le unicità e la capacità contributiva di generare cambiamento a beneficio di tutti.

Laureata in Filosofia e con un PhD in Social Sciences, è professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Cattolica di Milano, dove dirige anche la rivista Comunicazioni Sociali-Journal of Media, Performing Arts and Cultural Studies. Si occupa di trasformazioni culturali legati ai processi di globalizzazione e alla rete. È membro della Pontificia Accademia per la Vita, presidente del Comitato Tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, collabora con il quotidiano Avvenire e fa parte del comitato editoriale di Donne Chiesa Mondo, supplemento mensile dell’Osservatore Romano.